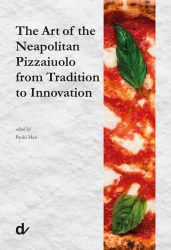Di fatto, grazie alla biologia, come genetista credevo di aiutare la gente a vedere più chiaro dentro di sé, chiedendo: «Cosa intende quando parla di razza?». E mostravo come fosse impossibile definirla senza ricorrere ad arbitri o ambiguità […] In altre parole, il concetto di razza si fonda sul nulla, e di conseguenza, il razzismo deve scomparire. Qualche anno fa avrei pensato che, con questa affermazione, avevo compiuto il mio lavoro di scienziato e di cittadino. Eppure, anche se non esistono le razze, il razzismo continua a esistere.
Sono passati più di trent’anni, ormai, da quando Albert Jacquard, genetista ma anche scrittore di scienza francese, ci invitava a non cadere nell’illusione illuminista per cui se dimostro l’infondatezza del concetto di razza, elimino ipso facto il razzismo.
Non funziona così.
La scienza moderna ha ampiamente dimostrato che le razze non esistono, ma «il razzismo continua a esistere».
E, tuttavia, vale anche l’opposto. Non è che perché «il razzismo continua a esistere», la scienza deve tacere sulla infondatezza del concetto di razza.
Allo stesso modo alcuni tra noi propongono di togliere la parola razza dalla Costituzione (articolo 3) e da tutti gli atti ufficiali della Repubblica perché scientificamente priva di senso. Certo, anche se riuscissimo nella battaglia e la parola razza venisse eliminata, abbiamo piena consapevolezza che «il razzismo continuerebbe a esistere». Ciò non ci esime dal portarla avanti, questa battaglia. Non solo perché è una battaglia per la correttezza scientifica. Ma anche e soprattutto perché se anche razza e razzismo sono concetti differenti e capaci di vivere in maniera indipendente l’uno dall’altro, è anche vero che nel corso della storia sempre il razzismo ha sentito il bisogno, per legittimarsi culturalmente, di far leva sul concetto scientifico di razza.
Di più. Come scrive Michel Wieviorka (Lo spazio del razzismo, Il Saggiatore, 1993): «Bisogna dire prima di tutto, e in modo molto chiaro, che le scienze sociali hanno ampiamente contribuito all’invenzione del razzismo, alla sua formulazione teorica e colta».
Ci sono dunque un passato da riscattare da parte della comunità scientifica (sociale e non solo) e un presente possibile da evitare: la distinzione in razze della popolazione umana è ancora presente, sia pure a fin di bene, in alcuni ambiti della ricerca biomedica.
Ecco perché vale la pena ripercorrerla, sia pure a volo di uccello e senza pretesa di completezza, la storia di un concetto sbagliato: la storia del concetto di razza applicato alla specie umana.
Christian Delacampagne fa risalire questa storia alle origini del pensiero occidentale. Cioè, alla Grecia antica. E in effetti, già nel V secolo a. C., Erodoto si impegnò nella descrizione dei diversi popoli, soprattutto mediterranei, che aveva direttamente conosciuto o di cui aveva avuto notizia, indicandone il nome, la collocazione geografica, l’aspetto fisico, gli usi e i costumi. Per questo Erodoto si è meritato la definizione di padre delle scienze antropologiche, oltre che di padre delle scienze storiche.
Erodoto ha il grande merito di aver scritto in modo ordinato i risultati dei suoi studi e delle sue conoscenze. E Aristotele, un secolo dopo, ha elaborato una classificazione che costituisce una vera e propria tassonomia della diversità umana. Tuttavia anche altri popoli mediterranei, a cominciare dagli Egizi e dai Fenici, conoscevano svariate popolazioni «diverse»: da quelle nere dell’Africa sub-sahariana a quelle dell’India o delle steppe euroasiatiche. I Romani entrarono, infine, in contatto un po’ con tutte le diverse popolazioni dell’Africa e dell’Eurasia: comprese le popolazioni dell’Asia orientale, conosciute per via indiretta attraverso il commercio.
E così, nel I secolo d. C., Plinio il Vecchio inizia a chiedersi dove mai abbia origine tanta diversità. La sua risposta è piuttosto ingenua: la diversità anche morfologica tra le diverse popolazioni è una conseguenza diretta del clima. Nelle fredde regione settentrionali, quelle più lontane dal Sole, scrive Plinio: «le razze hanno pelle bianca come la neve, con capelli gialli che cadono diritti». Gli africani, invece, sono «bruciati dal calore del corpo celeste che è loro vicino, e nascono con un aspetto bruciacchiato, con capelli e barba riccioluti».
L’ingenuità di Plinio il Vecchio è certo estrema. Ma alla teoria climatica della diversità morfologica e culturale umana avevano già aderito, prima di Plinio, illustri studiosi, come Ippocrate e Aristotele, e aderiranno, dopo Plinio, studiosi altrettanto illustri, da Tolomeo a Galeno. Tutti pensano che il clima, la dieta, la natura dei luoghi e, in una sola parola, l’ambiente abbiano la capacità di influenzare le caratteristiche morfologiche e il modo stesso di comportarsi degli uomini. In discussione, semmai, è come l’ambiente esercita queste influenze. Agendo sul seme o agendo direttamente sul corpo, come è incline a pensare il vecchio Plinio? Certo è evidente a tutti che l’influenza dell’ambiente non è immediata: un africano dalla pelle nera non cambia colore se emigra nell’Europa del Nord e, viceversa, nessun bianco è mai diventato nero andando a vivere in Africa. Tuttavia molti pensano che se un uomo bianco va in Africa modifica se non l’epidermide, almeno i suoi comportamenti: va cioè incontro a quello che è definito un processo di «tropicalizzazione». Come dire: l’influenza dell’ambiente può essere diretta e, tutto sommato, rapida. Altri pensano, invece, che l’influenza dell’ambiente agisca sulla trasmissione dei caratteri ereditari. E sia, quindi, più indiretta e lenta. Ma abbastanza potente da generare diverse razze umane.
Ora, non è ben chiaro quale sia l'origine della parola razza. Probabilmente deriva dal latino radix o ratio, o magari dall'arabo raz. Ma, qualsiasi sia la sua etimologia, è certo che a lungo la parola non ha avuto il significato attuale (o meglio, del significato assunto a partire dal XVI secolo): di insieme di persone con comuni caratteristiche fisiche. Per gli antichi la parola razza richiamava più l’identità familiare che non l’identità genetica.
Anche nel pensiero cristiano, la filogenesi delle razze (o meglio, la teoria prevalente sulla filogenesi delle razze) ha origine nella storia familiare di Noè e dei suoi tre figli: Cam, Sem e Iafet. Cam, colpito dalla maledizione divina, dà origine a una famiglia con carnagione scura che andrà ad abitare l’Africa. Alcuni esegeti delle Sacre Scritture pensano che il colore della pelle dei Camaniti sia generata da un’affezione del sangue. Altri pensano che sia dovuta all’immaginazione che la mamma sul feto di Cush, uno dei figli di Cam. Tutti pensano che le caratteristiche somatiche e comportamentali appartengano alla famiglia e siano dovute alla espressa volontà di Dio.
Ciò vale, naturalmente, anche per i discendenti di Sem, che popoleranno il Medio e il Lontano Oriente. E vale per i pii discendenti (i Greci e i Latini) del pio Iafet, che andranno ad abitare in Europa, diventeranno cristiani ed elaboreranno teorie sulle razze umane indulgendo all’autoglorificazione. In definitiva, per molti autori cristiani le grandi razze non sono altro che le grandi famiglie discendenti da un progenitore comune: Noè.
Il concetto attuale razza, come gruppo di persone con caratteristiche fisiche e comportamentali definite, ha una storia piuttosto recente. Risale, come abbiamo detto, al XVI secolo, dopo le grandi scoperte geografiche e le conseguenti scoperte, da parte degli Europei, di ambienti, popolazioni, culture sconosciute. Tanta diversità spinge Carlo Linneo a riprendere il progetto aristotelico e tentare una tassonomia, una classificazione ordinata. Il genere umano, Homo, sostiene Linneo nella decima edizione del suo Systema naturae del 1758, appartiene all’ordine dei primati ed è costituito da due specie: Homo sapiens e Homo troglodytes.A quest’ultima appartengono le scimmie antropomorfe, tre cui gli orangutan. La specie sapiens è costituita invece da diversi sottogruppi, o razze: europeus, asiaticus, americanus, afer (africani), monstruosus e ferus (uomini inselvatichiti). Ma come distinguere tra questi gruppi, cui appartengono persone che differiscono in svariati modi e non senza continuità? Linneo sceglie alcuni caratteri che ritiene significativi. Compreso il modo di vestire. Rendendo con ciò evidente che la scelta dei caratteri razziali è tutt'altro che facile e tutt’altro che oggettiva.
Tuttavia le differenze culturali e somatiche esistono. E molte sono le domande che affollano la mente dei naturalisti.
Qual è l'origine di tanta diversità culturale ma anche somatica? Come mai esistono civiltà avanzate e civiltà primitive? E c'è una correlazione tra i caratteri culturali e i caratteri somatici dei diversi popoli?
Risposte che sono destinate ad avere grande influenza sono quelle del francese George-Louis Leclerc conte di Buffon, uno dei progenitori del pensiero evoluzionista. Nel secondo volume della sua Historie Naturelle, pubblicato nel 1749 e dedicato all’Historie de l’homme, Buffon propone una ipotesi sull’origine delle razze che è proprio di tipo evolutivo: «dopo essersi moltiplicati e diffusi sull’intera superficie terrestre, [gli uomini] andarono incontro a diversi cambiamenti dovuti all’influenza del clima, del cibo, dei modi di vita, delle malattie epidemiche e della mescolanza continua tra individui più o meno simili. All’inizio questi cambiamenti non erano così marcati, e determinavano soltanto varianti individuali; in seguito queste varianti divennero varianti della specie, perché l’azione continua di queste stesse cause le rese più generali, più marcate e più permanenti. Tali varianti si trasmettono di generazione in generazione, come le deformità e le malattie vengono trasmesse da padri e madri ai loro figli». Tuttavia, Buffon non si limita ad attribuire all'ambiente le caratteristiche morfologiche dei diversi tipi umani, come è ancora senso comune nel XVIII secolo. All'ambiente attribuisce, senza esitazione, anche la diversità culturale. E, soprattutto, definisce una scala gerarchica tra le diverse civiltà. Anzi, definisce anche una scala gerarchica tra le diverse caratteristiche morfologiche delle razze umane, a loro volta conformate a una scala di bellezza. Per Buffon i bianchi sono portatori di una bellezza somatica superiore, mentre i neri sono i più vicini alla animalità. Allo stesso modo tra i bianchi il livello di civiltà è il più alto, mentre tra i neri è il più basso.
In questa opera di classificazione gerarchica delle morfologie e delle culture umane, Buffon assume che ci sia una correlazione tra morfologia e cultura; che sia possibile collocare ciascun individuo in un gruppo (razza) portatore di caratteri morfologici e culturali precisi e che la massima variabilità interna a ogni gruppo (razza) è comunque inferiore alla variabilità media tra gruppi (razze). Ovvero: un uomo, un qualsiasi uomo, di razza nera, avrà necessariamente sia caratteristiche morfologiche che comportamentali diverse e inferiori rispetto a un uomo, a un qualsiasi uomo, di razza bianca.
Buffon è un grande naturalista. Ma commette un errore che molti scienziati commettono e che Tzevetan Todorov puntualmente rileva. Buffon parte dalle sue grandi competenze in fatto di scienze naturali, cerca di trasporre all’uomo ciò che ha osservato nel resto della natura e si avventura, infine, in una serie di affermazioni sul genere umano che non sono scientifiche, perché non sono suffragate né da fatti, né da osservazioni, ma solo da visioni metafisiche, inferenze logiche e pregiudizi.
Le risposte sono ancora insoddisfacenti, persino sbagliate, ma certo con Linneo e Buffon il problema della razza diventa un problema scientifico. Un problema su cui si esercitano molti naturalisti e filosofi nel corso del ’700, compreso Immanuel Kant. Che riconosce immediatamente quanto sia scivolosa la corda della classificazione e dell’origine della diversità umana. Kant, infatti, propone una classificazione delle razze umane e un’ipotesi sulla loro origine. Ma poi riconosce che il tutto è piuttosto superficiale e fondato su una pressoché assoluta mancanza di dati. Il problema scientifico esiste: quella che non c’è ancora è la capacità di fornire risposte scientifiche.
È, dunque, per iniziare a colmare la lacune dei dati di fatto che il giovane Johann Friedrich Blumenbach dedicala sua tesi di laurea in medicina al De generis humani varietate nativa e nel 1775 a Göttingen propone una classificazione delle razze umane basata, almeno in parte, su osservazioni di tipo quantitativo, come lo studio della forma del cranio. Blumenbach, che è oggi considerato il padre dell’antropologia fisica, sostiene che la specie umana è una sola, distinta in cinque diverse razze: la caucasica, formata dagli abitanti dell’Europa, dell’Africa settentrionale, del Medio Oriente e dell’India; la mongolica, formata dagli orientali ma anche da Finlandesi e Lapponi; la etiopica, formata dalle popolazioni nere dell’Africa sub-sahariana; l’americana, formata dagli indigeni di quel continente; e, infine, la malese, formata dagli abitanti degli arcipelaghi del sud-est asiatico e della parte dell’Oceania allora conosciuta. Blumenbach afferma la sua convinzione che l’uomo è nato nel Caucaso, nell’area dove tuttora vivono le genti più belle. E che tutte le altre razze siano state il frutto di un processo evolutivo e, in qualche modo degenerativo, della razza bianca originaria.
L’idea della degenerazione non è nuova. Essa appartiene da tempo alla mitologia delle razze umane. E, in particolare, appartiene all’idea monogenetica: secondo cui, appunto, l’umanità ha una origine unica e comune. I fautori di questa idea sono convinti che Adamo ed Eva, progenitori dell’intera umanità, furono creati da Dio con la pelle bianca. E che anche Noè e i suoi figli fossero bianchi. Poiché la razza bianca è quella di più piacevole aspetto e di più alta cultura, va da sé che il processo di diversificazione delle razze è stato in realtà un processo di degenerazione. A nessuno viene in mente, neppure a Blumenbach, che la razza bianca appare di più piacevole aspetto e di più alta cultura a osservatori che sono bianchi e depositari della cultura dei bianchi.
L’idea monogenetica è quella prevalente, tra i pensatori cristiani, perché è conforme alla narrazione biblica dell’origine dell’uomo. Tuttavia esistono anche idee poligenetiche, che prevedono svariati atti creativi da parte di Dio. Ogni razza, secondo questa ipotesi, sarebbe il frutto di un atto di creazione diverso e indipendente. E la gerarchia tra le razze umane non sarebbe il risultato di una diversificazione degenerativa difficile da spiegare, ma sarebbe una limpida struttura a priori. I bianchi sono superiori agli altri per decisione originaria di Dio.
Sia il frutto di una evoluzione degenerativa o di un originario atto creativo, pochi dubitano che le razze esistano e che le differenze biologiche tra loro siano enormi. Tanto che più d’uno mette in dubbio la completa interfertilità tra i diversi gruppi di umani. Insomma, l’umanità più che da diverse razze sarebbe costituita da diverse specie.
Quella della gerarchia tra le razze (o, addirittura, tra le specie) diventa una teoria scientifica intorno alla fine del ’700, in seguito agli studi frenologici di Franz Joseph Gall che sviluppa gli studi di antropologia fisica di Blumenbach e inizia a misurare in modo sistematico le dimensioni dei crani e le forme delle teste, correlandole sia alle capacità intellettuali che morali. Alcuni anni dopo, il francese Lambert-Adolphe-Jacques Quételet inaugura la disciplina della biometria e l’anatomista svedese Anders Retzius introduce negli studi di biometria applicati all’uomo un parametro quantitativo semplice e preciso, l’«indice cefalico»: il rapporto tra larghezza e lunghezza del cranio. Il parametro ha un indubbio successo e resterà un fondamento dell’antropometria per un secolo e oltre. La sua fortuna inizierà a declinare solo dopo la seconda guerra mondiale, quando sarà dimostrato che l’indice ha una scarsa correlazione con l’ereditarietà e che è estremamente sensibile a effetti ambientali a breve termine.
Nel 1852 il conte Joseph Arthur de Gobineau pubblica un libro destinato a diventare celebre: l’Essai sur l’inégalité des races humaines. In questo saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, considerato forse a torto, l’atto fondativo del razzismo scientifico, il nobile francese non cerca solo di portare dei fatti a sostegno dell’esistenza delle razze e della loro gerarchia – i bianchi, ovviamente, sono la razza superiore – ma sostiene che la pericolosità del mescolamento tra persone di razze diverse, perché causa della degenerazione dei popoli e delle civiltà.
Occorre attendere solo fino al 1859 e alla pubblicazione di On the Origins of Species perché Charles Darwin metta un primo punto fermo sul problema delle razze: le specie viventi, compresa quella umana, non sono entità statiche, ma si modificano nel tempo ed evolvono adattandosi ai cambiamenti dell’ambiente. Non ci sono specie o razze migliori in assoluto, ma solo specie e razze più o meno adatte a sopravvivere in un ambiente che cambia.
Un secondo e più diretto punto fermo Charles Darwin lo mette dodici anni dopo, nel 1871, quando pubblica L’origine dell’uomo. Darwin sostiene la completa interfertilità tra le presunte razze umane, perché ciascuna «confluisce gradualmente nell’altra». L’uomo forma una sola e unica specie, perché quelle che vengono chiamate razze non sono abbastanza distinte da abitare una medesima regione senza fondersi. Anzi, queste presunte razze sono così simili le une alle altre, che non esistono due autori che abbiano ottenuto, cercando di classificarle in modo obiettivo, il medesimo risultato. Cosicché le differenze tra queste presunte razze, benché talvolta appaiano vistose, sono del tutto irrilevanti. Mentre, al contrario, vi è una grande uniformità nelle caratteristiche davvero importanti, comprese quelle mentali: malgrado le apparenti differenze che gli africani o gli indigeni d’Amazzonia mostrano rispetto agli Europei, Darwin si dice colpito ogni volta che rivela persino dai tratti più piccoli del carattere «come le loro menti siano simili alle nostre».
L’origine della grande variabilità tra gli uomini, tuttavia, esiste, sostiene Charles Darwin. Ed è probabilmente il frutto di una selezione sessuale. Una selezione che il teorico dell’evoluzione biologica ritiene distinta dalla naturale.
Quello di Darwin è un autentico e autorevole manifesto antirazziale. Il primo contributo chiaro che il pensiero scientifico propone contro le discriminazioni tra le razze. Queste, sostiene Darwin, sostanzialmente non esistono.
Ciò non toglie che l’approccio di Darwin non sia risolutivo. Neanche in ambito scientifico. Fermiamoci al solo ambito sociologico e antropologico. Ancora a fino Ottocento, in Francia, Georges Vacher de Lapouge cerca di fondare, per l’appunto, una sociologia antropologica in cui si cerca di corroborare con il ricorso a dati biologici e di antropologia fisica l’esistenza di una sorta di potenziale di degenerazione associato al meticciato. In altri termini, l’incrocio tra le razze non è un bene.
In Inghilterra, persino il cugino di Darwin, Francis Galton, promuove l’eugenetica sulla base delle sue forti convinzioni sulle differenze razziali. Galton influenzerà non poco il dibattito nella nascente Sociological Society of London.
In Italia, Cesare Lombroso porta avanti studi molto dettagliati sul rapporto tra razza e criminalità, sostenendo, tra l’altro, che in Italia esistono due diversi tipi – il settentrionale e il meridionale, il primo di origine nordica e ariana, il secondo di origine negra e africana. E che quest’ultimo è più incline a commettere crimini, a vagabondare e ad abbandonarsi alla pigrizia.
In Germania, Otto Ammon assume un approccio positivista á la Vacher de Lapouge e per questo è considerato uno dei profeti del nazismo. Mentre l’inglese di origine ma naturalizzato tedesco Houston Stewart Chamberlain condanna il “caos delle razze” e indica il pericolo della crescente influenza, a suo dire, degli Ebrei.
Contro Chamberlain e contro il medico Alfred Ploetz, fondatore della Rassenhygiene (l’igiene della razza) si schiera in maniera netta Max Weber. Ma neppure lui rinuncia al concetto di razza, che si sostanzia solo quando vi è associata una “coscienza di razza”.
Tutti questi discorsi di scienziati naturali e sociali, va da sé, sono chiamati a corroborare di volta in volta il razzismo e l’antirazzismo.
Il razzismo che ha innervato la cultura europea per molti decenni tra il XIX e la prima parte del XX secolo – quando supera l’esame di ammissione al Politecnico di Zurigo nella giustificazione ufficiale si cita il fatto che sebbene sia un Ebreo è una brava persona – e sfocia nelle leggi razziali naziste (1933), italiane (1938) e di molti altri paesi europei. Un razzismo che poi distilla l’Olocausto, che è il tentativo di eliminare una “razza” (anzi, due, perché spesso ci dimentichiamo del genocidio degli zingari). Ebbene in questo tragico percorso, durato per l’appunto decenni, il razzismo cerca sempre di fondarsi sul concetto biologico di razza.
Un concetto che già in piena guerra subisce colpi decisivi. L’antropologo americano Franz Boas, per esempio, nel 1940 pubblica uno studio sui caratteri antropometrici e morfologici dei figli degli immigrati negli Stati Uniti d’America in rapporto a quelli dei parenti rimasti nella madre patria. Benché con qualche superficialità di tipo statistico, Boas dimostra che gli effetti ambientali a breve termine sono importantissimi su parametri come la statura e che non ci sono sostanziale differenze tra immigrati provenienti da regioni diverse.
Non è l’antropometria, tuttavia, ma la genetica a porre la parola fine al dibattito scientifico sulle razze. Lo studio della caratteristiche genetiche ha dimostrato che la specie umana è una sola, che ha avuto medesima origine in Africa, circa 200.000 anni (o forse oltre 300.000 anni) fa, e che al suo interno non ci sono ragioni obiettive per individuare una tassonomia di profili genetici ben definiti. Per tre motivi, molto ben chiariti dagli studi sistematici dell’italiano Luigi Luca Cavalli-Sforza.
- Se si considerano singoli caratteri, o meglio singoli geni, essi sono sempre presenti in quasi tutte le popolazioni umane, anche se con frequenza diversa. In pratica, per la frequenza dei singoli geni, tutte le popolazioni umane si sovrappongono. E nessun gene può essere utilizzato per distinguere una popolazione umana dall’altra.
- C’è una grande variabilità genetica, tra gli uomini. Nessuno di noi porta i medesimi geni di un altro individuo. Tuttavia la gran parte di questa variabilità è anteriore alla formazione delle diverse popolazioni ed è probabilmente persino anteriore alla formazione della specie sapiens.
- La variabilità genetica all’interno delle singole popolazioni, per esempio tra gli europei o tra gli italiani, è elevatissima. Mentre le differenze genetiche tra i tipi mediani delle diverse popolazioni, tra gli italiani e gli etiopi, per esempio, sono modeste e pressoché irrilevanti rispetto alla variabilità interna alle singole popolazioni. C’è maggiore differenza tra due italiani posti all’estremo di un profilo genetico, che non tra un italiano e un etiope posti al centro dei profili delle rispettive popolazioni. Le eventuali derive genetiche tra le varie popolazioni della Terra sono infine continuamente annullate dalle migrazioni e dalla fusione tra individui che abitano le medesime regioni. Le differenze vistose che pure ravvisiamo tra le diverse popolazioni, per esempio il colore della pelle, sono marginali. Effetto di lungo periodo del clima e, probabilmente, della selezione sessuale.
Aveva dunque ragione Darwin. Ma c’è voluto più di un secolo prima che le comunità scientifiche accettassero l’idea che le razze non esistono. Mentre continua a esistere il razzismo.