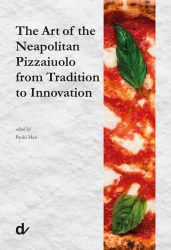«L’elemento fantastico della speranza dei saperi che trasformino, insieme al freno severo ma stimolante di ogni investigazione critica, stanno alla base di ogni possibile asserzione di oggettività o razionalità che non sia minata da inaudite negazioni e repressioni»
Donna J. Haraway
«Il 25 aprile 2016 un ragazzo di 17 anni affetto da distrofia muscolare di Duchenne guidava la sua carrozzella elettrica nella sala conferenza dove la Food and drug administration (Fda) teneva le audizioni degli esperti incaricati di valutare l’efficacia e la tollerabilità di eteplirsen, un composto sperimentale per il trattamento della sua malattia. Prendendo il microfono davanti a una commissione di esperti e consulenti della Fda, il ragazzo, Austin Leclaire, dichiarava: “(questo farmaco) mi ha permesso di mangiare da solo, mi ha dato una possibilità. È tempo di ascoltare i veri esperti”»
«Le PWA (People With AIDS) e le PWARC (People With AIDS Related C...) di New York iniziarono ad esprimere frustrazione crescente nel partecipare a troppi incontri di GMHC[1] durante i quali quelli che tra di noi avevano l’AIDS sedevano silenziosamente tra il pubblico ascoltando dottori, infermieri, giuristi, esperti di assicurazioni e lavoratori sociali che ci istruivano sula condizione di avere l’AIDS. Molti di noi notarono nello stesso momento [...] che sembrava esserci qualcosa di sbagliato in quest’immagine. Ci rendemmo conto che i “veri esperti” non erano lassù [...] L’idea ci colpì come un fulmine. Fino a quel momento, nessuno tra di noi che eravamo stati trovati sieropositivi aveva pensato che potessimo essere nient’altro se non recipienti passivi della cura e dell’attenzione genuina di coloro che non erano (ancora) risultati positivi».[2]
Le situazioni descritte in questi due brani hanno, evidentemente, degli elementi comuni. In entrambe, di fronte ad una schiera di medici e professionisti del settore sanitario, persone qualificabili come “esperti”, un malato rivendica le proprie, peculiari e - in un certo senso - più vere competenze di “esperto”. I brani ci colpiscono perché in essi il concetto di “esperto” subisce uno slittamento di senso inaspettato; viene da chiedersi, terminata la lettura, in che modo nel corso delle narrazioni la sua semantica cambi finendo per essere associato, piuttosto che al professionista, al malato. Oltre alle somiglianze, ci accorgiamo poi di una differenza fondamentale: nella prima situazione, il “malato” esterna la propria rivendicazione agli esperti; parla loro pubblicamente, avendo un ruolo riconosciuto (impugna l’emblematico microfono); nella seconda, la rivendicazione è frutto di un ragionamento privato, stimolato dal sentimento di essere stato accantonato e ammutolito riguardo a qualcosa in cui si sente coinvolto. Il primo brano descrive un evento accaduto nel 2006 ed è estrapolato da un articolo[3] pubblicato in un numero della rivista Forward dedicato al ruolo del paziente nella ricerca e nella pratica clinica medica. Il secondo viene da uno scritto che ricostruisce gli anni dello scoppio dell’epidemia di AIDS dal punto di vista dell’autore, Michael Callan, malato e attivista.[4]
Ritengo che queste analogie non siano meramente formali; piuttosto, credo che esse mettano a nudo un processo di cambiamento concettuale. Oggi si afferma che «L’idea di coinvolgere il paziente nei processi decisionali che riguardano l’assistenza sanitaria e all’interno della ricerca clinica è diventato una sorta di mantra negli ultimi anni»; la storia dell’attivismo AIDS dimostra che negli anni ottanta, negli USA, l’idea che il paziente potesse essere considerato “esperto” non era contemplata. Ciò che vorrei portare alla luce in questo articolo è che l’esperienza dell’attivismo AIDS ebbe, oltre agli ampiamente riconosciuti meriti pratici, un notevole valore epistemico, avendo contribuito alla ridefinizione del ruolo del paziente e dei concetti di competenza nella ricerca medica. Nel farlo seguirò principalmente le ricostruzioni storiche di Steven Epstein e mi concentrerò soprattutto sull’attivismo definito “terapeutico”.[5]
Il 1984 segnò un punto di svolta nella ricerca sull’AIDS; fino a quel momento la nuova malattia[6] che stava falcidiando principalmente – ma non solo – le comunità gay era avvolta da una fitta nebbia, impenetrabile all’occhio scientifico ed essere malato di AIDS equivaleva ad una condanna a morte. Nell’84 si isolò il retrovirus che oggi chiamiamo HIV; si poté dunque iniziare a studiarne il funzionamento e si riflettere per la prima volta su possibili strategie in grado di portare ad una terapia. Un farmaco già esistente, l’azidotimidina (AZT), si rivelò in grado di inibire la trascrittasi inversa del virus HIV in condizioni da laboratorio.[7] Da questo momento iniziarono le sperimentazioni su pazienti per testare l’efficacia e la tossicità del farmaco. Furono organizzate in “doppio cieco”, un modello sperimentale che prevede la divisione in due gruppi dei soggetti della ricerca (ovviamente tutti malati): ad un gruppo viene somministrato il farmaco sperimentale, all’altro un placebo, compresse fenomenicamente identico al farmaco in studio ma privo del principio attivo. Fondamentale è che né i soggetti dello studio né i medici che raccolgono i dati siano a conoscenza del tipo di medicinale che si assume, di modo che gli interventi soggettivi che potrebbero alterare i dati siano minimizzati. Studiando a lungo termine i due gruppi si possono così monitorare gli effetti del farmaco.
Le cose non andarono però esattamente come programmato. Più soggetti furono scoperti a scambiarsi le compresse, riconoscendo il composto dal sapore o tramite analisi di laboratorio. Ancora, alcuni assumevano farmaci non in commercio negli Stati Uniti, dalla quantomeno dubbia efficacia; popolare era la ribavirina, importato dal Messico da gruppi di acquisto sul filo della legalità, i Buyers’ Club. Nel 1986 si iniziò inoltre a diffondere, parallelamente alla ricerca ufficiale, una rete di contatti e di informazioni gestita principalmente da PWA (come Martin Delaney, fondatore dell’importante network Project Inform) che cercava di diffondere l’AZT e altre possibili cure che non erano state prese in considerazione dalle istituzioni sanitarie e di studiarne gli effetti. Queste assunzioni di farmaci non previste finirono per inquinare i test. Casi come questi vennero etichettati come casi di noncompliance – di non collaborazione. I soggetti disobbedienti erano visti come irresponsabili e pericolosi, poiché non rispettando gli impegni presi con l’adesione ai trials finivano per remare contro allo sviluppo di una cura. D’altra parte, per chi aveva avuto la diagnosi di malattia conclamata, la partecipazione ai trials era l’unico modo per accedere a qualcosa che poteva assomigliare ad una cura; poco importa in fondo se l’AZT è tossico - pensavano alcuni – dato che al momento è la nostra unica speranza. Epstein riporta le lapidarie parole di Delaney: «Non sappiamo con certezza se queste droghe funzioneranno, ma [assumerle] ha più senso che l’unica alternativa, ossia morire senza provare alcunché».[8] Mentre gli esperimenti a doppio cieco si concentravano su un solo farmaco e richiedevano tempo, molti malati sentivano di non averne affatto.
La ricerca medica non aveva tuttavia alcuna intenzione di rinunciare al placebo e al doppio cieco: nonostante i molti casi che testimoniassero l’insofferenza dei pazienti a queste pratiche, essi erano visti come garanzia insostituibile di produzione di dati affidabili e utili. Lo storico della scienza Theodore M. Porter giustifica questa rilevanza mostrando che l’adozione del doppio cieco come standard di ricerca sia stato uno dei capisaldi del rinnovamento della medicina nel dopoguerra; in questi anni l’analisi statistica si impose come passaggio fondamentale nello sviluppo delle terapie, grazie anche all’azione e al pensiero dell’epidemologo Austin Bradford Hill. Hill si ispirava ad un ideale helmoltziano di scienza come pura misurazione, per la quale «l’opinione dei medici praticanti riguardo al successo del trattamento e alla salute del paziente erano sostituti scadenti del conteggio dell’emoglobina e dei tassi di sedimentazione come indicatori dei risultati».[9] D’altronde questa concezione può essere letta come sviluppo di un approccio alla patologia, divenuto maggioritario nel corso del XIX secolo, che ricerca la pura descrizione e misurazione oggettiva, facendo dell’elemento soggettivo un disturbo da minimizzare.[10] Proprio in questo contesto nacque il trial clinico in doppio cieco: venne perfezionato dallo stesso Hill come miglior modo per produrre evidenze oggettive e si impose come modello di rigore scientifico, e divenne negli anni Sessanta lo standard richiesto dalla FDA (Food And Drug Amministration, organismo degli Stati Uniti deputato alla regolazione della commercializzazione dei farmaci) per valutare l’efficacia e la sicurezza dei composti in prova. Non importava di quale tipo di farmaci si parlasse, dallo sciroppo per la tosse a anti tumorali, la FDA richiedeva il doppio cieco.[11]
Questo braccio di ferro determinò lo sviluppo dell’attivismo, fino a quel momento principalmente assistenzialista, in “attivismo di trattamento”, che si confrontò polemicamente con il modo in cui venivano collezionati i dati scientificamente rilevanti. In particolare il neonato ACT UP nel biennio ‘87/’88 organizzò una serie di manifestazioni contro la FDA, ritenuta il «posto di blocco sulla via per l’accesso ai farmaci per AIDS». Esponendo grandi orologi o simulando la propria morte e sepoltura sotto una lapide con su scritto «FDA killed me», il messaggio che volevano far passare era sostanzialmente uno: non abbiamo tempo. [12] Ciò era esattamente quello che gli esperti, che – per il bene dei pazienti – attendevano risultati sicuri prima di diffondere i farmaci, parevano non capire. ACT UP volle esprimere e rappresentare un paradosso: in vista di un’astratta cura che godesse di inequivocabili garanzie, venivano sacrificate possibilità di cura concrete e presenti. «È come se fossi un passeggero su un aereo che cade giù a velocità folle, senza controllo. Vedo un paracadute appeso ad una parete, mi sorge una piccola speranza. Cerco di prenderlo ed ecco che un impiegato mi raggiunge e me lo strappa dalle mani, ammonendomi: “Non puoi usarlo! Non ha lo sticker della Federal Aviation Amministration. Non sappiamo se funzionerà!”».[13]
Vorrei suggerire che il forte contrasto tra i due punti di vista possa essere letto come segno del mancato riconoscimento delle competenze proprie dei malati. Le persone con AIDS – gridava ACT UP, gridava Michael Callan - vengono trattate come oggetti, ispezionati da un implacabile automa indifferente al fatto che fossero loro, nella loro esperienza quotidiana, a dare (il) corpo alla malattia. Rifacendoci al pensiero di autori come Karl Jaspers e Georges Canguillhem, potremmo dire che in quel momento storico (e per la situazione di emergenza) la medicina aveva perso la capacità di cogliere il carattere “qualitativo” della malattia, ossia il suo valore concreto a partire dal quale si possono progettare ricerche quantitative e statistiche.[14] Canguillhem sostenne che se la malattia fosse «una realtà oggettiva accessibile alla conoscenza scientifica quantitativa [...] la differenza di valore che il vivente istituisce tra la propria vita normale e la propria vita patologica» sarebbe «un’apparenza illusoria che lo scienziato è legittimato a negare»;[15] gli effetti fisiologici e i sintomi morbosi della malattia sarebbero dunque irrilevanti da un punto di vista patologico.[16] Tuttavia, sosteneva il filosofo francese, il concetto di “normalità”, che indica lo stato da ristabilire, non può essere ricavato in modo univoco, bensì solo stabilito. Esso non è una semplice realtà data da una media, bensì una norma, un’imposizione di valore che viene espressa (o meglio fatta propria) da un soggetto, e solo in un secondo momento può essere ricercata numericamente associandola a fenomeni quantificabili. D’altronde, il concetto stesso di “patologia” è per Canguillhem qualitativo, avendo una connotazione intrinseca di negatività intraducibile nel linguaggio, per esempio, della meccanica.[17] La patologia – in quanto «alterazione dello stato normale»[18] - sarebbe percepibile solo a livello della totalità individuale,[19] e la sua descrizione quantitativa è, in un certo senso, un formidabile stratagemma conoscitivo, insostituibile ma che non può prescindere dall’elemento soggettivo. Così anche la terapia, intesa come tentativo di ristabilire lo stato normale, non è tale se non prende in considerazione cosa sia tale normale nel proprio preciso contesto.
Chiaramente per Canguillhem il punto non è che la riduzione quantitativa in medicina non abbia senso, bensì che lo acquisti solo a seguito di una riflessione concreta sul senso dell’essere malati. Credo che quest’idea sia avvicinabile a quella di Porter, che afferma: «I am arguing, though, that they work mainly as social technologies, not as guides to private thinking». Se si delega la riflessione alla tecnologia possono generarsi dei paradossi clinici, come per esempio la sospensione della profilassi per pneumocystis carinii (una delle infezioni più comuni tra i malati di AIDS) imposta ai partecipanti poiché avrebbe interferito con la raccolta dei dati. [20]
Ritengo che le manifestazioni a carattere teatrale di ACT UP lavorassero proprio per costruire un “senso” condiviso della malattia e per comunicarlo a chi sapeva poco dell’epidemia e alle istituzioni mediche, facendo pressioni affinché fosse riconosciuto. Tuttavia, dopo essersi confrontati con la FDA, gli attivisti si resero conto che, per essere ascoltati, avrebbero dovuto entrare nel merito delle questioni dei trials. [21] Cercarono dunque di intavolare un dialogo con gli istituti che organizzavano la ricerca terapeutica, il NIH (National Institute of Healt) e il NIAID (National Institute of Allergy and Infectous Diseases). È possibile, (si) chiedevano, immaginare dei trials che non impieghino i placebo, che permettano un accesso ampio ai farmaci in prova e non vietino a chi vi partecipa di assumere le cure di profilassi per le malattie secondarie? È possibile insomma produrre conoscenza che tenga conto dalla loro esperienza di malattia, o invece questa stessa esperienza rema contro la scienza? Per essere ammessi alla discussione di queste problematiche e per comprenderle a fondo gli attivisti intrapresero un processo di “divenire-esperti” (expertification), ossia di familiarizzazione con la disciplina biomedica. Le nuove competenze fecero lentamente cambiare opinione a molti ricercatori nei confronti degli attivisti: dal momento in cui divenne chiaro a tutti che il dibattito non verteva sull’alternativa scienza/non scienza, bensì tentava un rilancio in direzione di una “scienza migliore”, iniziò una proficua collaborazione tra i due lati della barricata. Anthony Fauci, ai tempi direttore del NIAID, affermò in un intervista del 1989: «All’inizio, queste persone provavano solo disprezzo nei nostri confronti, e noi ricambiavamo. Gli scienziati dicevano che tutti i trials dovevano essere ristretti, rigidi e lenti. I gruppi gay dicevano che uccidevamo le persone. Quando la situazione si chiarì, realizzammo che molte delle loro critiche erano assolutamente valide». In molti si convinsero che non erano sempre necessari test dai tempi lunghi per produrre conoscenza valida, che a volte i placebo potevano essere evitati, e che si potevano disegnare trials validi permettendo a molte persone di accedere ai farmaci sperimentali. David P. Byar, ai tempi biostatico dell’ NCI, ammise: «Penso che ci sia stata una visione limitata e con poca immaginazione di come i trials debbano essere condotti».[22]
Le idee sostenute dagli attivisti non vennero prese sul serio unicamente perché ritenute eticamente rilevanti; le loro proposte non vennero percepite come un rallentamento, necessario ma pur sempre fastidioso, della ricerca, bensì come un suo potenziamento. Per esempio, organizzando sperimentazioni che non prevedevano placebo, diminuì notevolmente la percentuale di noncompliance. Gli attivisti – nonostante fossero ancora limitati da ovvie carenze – risultarono avere una capacità unica nell’organizzare i trials, essendo capaci di indovinare la forma che avrebbe riscosso più successo nella comunità.[23] E questo non era dovuto solamente all’esperienza dello studio biologico, quanto a quel carattere di “esperti della malattia” che possedevano in quanto soggetti malati.
Ecco dunque che, alla luce di esperienze come questa, seppure si sta ancora cercando di trovare una collocazione precisa al paziente nel campo della ricerca medica, se ne riconosce oggi il contributo irrinunciabile. Non si vuole pensare a una svalutazione delle basi statistiche della ricerca in medicina, quanto piuttosto suggerire che le esigenze che essa pone possano, in alcune situazioni, divenire tiranniche e controproducenti. La ricerca quantitativa acquista senso solo a partire da una riflessione concreta e soggettiva (dunque non del tutto tecnicizzabile) sul senso dell’essere malati. Vorremmo descrivere quest’idea di «sapere situato» (sapere che procede da un posizionamento, non scindibile dalla situazione del soggetto) con le parole di Donna Haraway, che sostenne che un punto di vista marcatamente soggettivo non esclude la possibilità di raggiungere un’oggettività, ossia una conoscenza con pretesa di verità: «Solo una prospettiva parziale permette una visione oggettiva [...] Avere corpo [infatti] è una protesi significante».[24] Interpreterei questa breve e colpevolmente sommaria ricostruzione storica come un caso in cui la scienza contemporanea è riuscita ad integrarsi con un tipo di expertise marcatamente situata, cui ha fornito un linguaggio e ha permesso di divenire sapere, consci del fatto che «Non siamo direttamente presenti a noi stessi. La conoscenza di sé richiede una tecnologia semiotico-materiale che unisca significati e corpi».[25]
[1] . Gay Men Health Crisis, organizzazione senza scopo di lucro che dal 1982 si dedica alla lotta all’AIDS.
[2] Questa e le seguenti traduzione dall’inglese, ove non sia esplicitamente indicato altrimenti, sono state da me eseguite; anche il grassetto è mio. Per una storia dell’attivismo AIDS, cfr. R. A. Smith, P. D. Siplon, Drugs Into Bodies: Global AIDS Treatment Activism, Greenwood Publishing Group 2006
[3] G. Recchia, R. Barbon Galluppi, S. Mazzariol, C. Taranto, Paziente esperto, da passeggero a co-pilota della ricerca terapeutica? in Forward 3, 2016
[4] M. Callan, D. Turner A History of the People With AIDS Self-Empowerment Movement, Body Positive dicembre 1997
[5] Cfr. S. Epstein Impure science, Berkeley, University of California Press 1996. Per un’analisi puntuale del contributo dell’attivismo alla ricerca e alla pratica medica, cfr. John Y. Killen Jr. HIV Research in AAVV The Oxford Textbook of Clinical Research Ethic, Oxford University Press 2008
[6] Sul concetto di “nuova malattia” cfr M. Grmek AIDS. Storia di un’epidemia attuale, Roma-Bari, Laterza 1989
[7] Cfr. S. Epstein op. cit. p. 192
[8] Cfr. S. Epstein op. cit. p. 188
[9] M. Porter Trust in numbers, Princeton (New Jersey), Princeton University Press 1996 pp. 204/205
[10] Michel Foucault cercò le origini di questo sviluppo della medicina moderna nella patologia del ‘600: «La perturbazione primaria è portata dal malato stesso. Alla pura essenza nosologica […] il malato aggiunge, come altrettante perturbazioni […] tutta una serie di eventi che, rispetto al nucleo essenziale, figurano come accidenti»; M. Foucault La nascita della clinica, Torino, Einaudi 1969, p. 20. Riguardo allo sviluppo della patologia nel XIX sec cfr. anche la prima parte di G. Canguillhem Il normale e il patologico, Torino, Einaudi 1998
[11] Cfr. M. Porter op. cit. p. 206
[12] Cfr. S. Epstein op. cit. pp. 224/225
[13] M. Delaney The case for patient access to experimental therapy, in The Journal of Infectious Diseases vol. 159 n. 3 marzo 1989
[14] Cfr. K. Jaspers Il medico nell’età della tecnica, Milano, Raffaello Cortina Editore 1991 G. Canguillhem op. cit.
[15] Ivi pp. 50/52
[16] Ibidem
[17] «Si dirà che un tempo Aristotele ha creduto a una meccanica patologica perché ha creduto in due tipi di moti: i moti naturali […] e i moti violenti […] La meccanica moderna, fondando la scienza del movimento sul principio d’inerzia, rendeva di fatto assurda la distinzione [...] Quando i residui dell’alimentazione non sono più escreti da un organismo e ostruiscono o intossicano l’ambiente interno, tutto ciò è conforme alla legge (fisica, chimica, ecc.), eppure nulla è conforme alla norma che è l’attività dell’organismo stesso», ivi p. 98
[18] Ivi p. 62
[19] Nel linguaggio vivido dell’autore: «la malattia non riguarda i reni per via della glicosuria, né il pancreas per via dell’ipoinsulinemia, e neppure l’ipofisi; la malattia riguarda l’organismo: tutte le sue funzioni sono modificate, la tubercolosi lo minaccia, le infezioni in suppurazione non hanno fine, l’artrite e la cancrena rendono inutilizzabili le membra; e più ancora, la malattia è dell’uomo e della donna, minacciati dal coma, spesso colpiti da impotenza e sterilità, per cui la gravidanza, se si verifica, è una catastrofe in cui le lacrime – ironia delle secrezioni! – contengono zucchero», p. 62. Canguillhem parla del diabete, ma ciò è tanto più vero per l’ AIDS, patologia comune a situazioni cliniche che possono essere piuttosto differenti
[20] Cfr. S. Epstein op. cit. p. 202
[21] «Sebbene la questione della libertà personale di usare un trattamento, che funzioni oppure no, la questione più importante è quale trattamento effettivamente funzioni, e come possono essere collezionate, valutate, e applicate velocemente ed efficacemente», FDA relaxes drug access politics, da AIDS Treatment News, 29 luglio 1988.
Bisognerebbe tenere presente che attivismo è molto composito. Per esempio, Project Inform si dedicò a questo problema molto prima di ACT UP
[22] J. Palca AIDS drugs trials enter new age in Science, New Series, Vol. 246, No. 4926, p. 20
[23] Cfr. S. Epstein op. cit. p. 341
[24] D. J. Haraway Manifesto Cyborg, Milano, Feltrinelli 1995, p. 119. Anche Epstein cita il concetto di «sapere situato», cfr. op. cit. pp. 340/343
[25] Ivi, p. 116